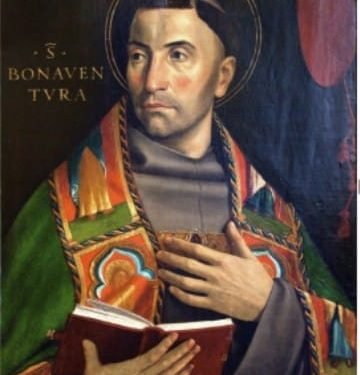L’obiettivo principale della presente tesi è quello di portare un contributo al dialogo tra scienza e fede, riguardo al tema dell’origine dell’universo, che la fede attribuisce all’atto creativo di Dio.
Come prospettiva a partire dalla quale verificare la possibilità di un simile dialogo tra scienza e fede, ho scelto il pensiero di Bonaventura: egli infatti elabora una riflessione teologica sulla creazione fondata sul paradigma trinitario. Il punto di partenza del dottore serafico è il manifestarsi di Dio. “La categoria che meglio riassume questo tema, più che quella dell’essere, che allude a ciò che Dio è in sé, è perciò la categoria del bene, che rimanda al come Dio si offre”[1]. Verrà messo alla luce che per Bonaventura, Dio è il Supremo Bonum communicativum.
Sulla base di questa ipotesi di ricerca, lo studio della tesi si è strutturato in quattro capitoli che, attraverso l’analisi del pensiero di Bonaventura, arrivano a considerare come esso possa contribuire ad una considerazione teologica del mondo creato aperta all’interpretazione scientifica.
Il punto centrale trattato nel Primo Capitolo è l’argomentazione di Bonaventura su Dio come il principio creatore. Nel secondo libro del Commento alle Sentenze troviamo la sua ratio creationis. L’ultimo dei sei argomenti che lui propone, che costituisce “l’argomento principale”[2],è espresso in forma sillogistica: “È impossibile che ciò che ha l’essere dopo il non essere abbia un essere eterno, perché vi è un’implicata contraddizione; ma il mondo ha l’essere dopo il non essere; quindi è impossibile che sia eterno”[3]. Va detto che il ritenere che il mondo sia eterno è semplicemente contro la verità e la ragione[4].
A differenza di San Tommaso, secondo il quale l’inizio del mondo è un “articulus fidei”[5] in cui si può credere ma di cui non si può avere conoscenza scientifica, Bonaventura sostiene che la ragione può stabilire sicuramente l’inizio del mondo nel tempo[6]. Di conseguenza, come sottolinea Bigi, “non ha senso chiedersi se può essere stato creato il tempo prima delle cose; il tempo è in stretta relazione con il divenire”[7]. In questa prospettiva, la creazione è intesa come un ordine che dice intrinseca successione dal non essere all’essere[8].
Da Tommaso l’ipotesi dell’eternità del mondo comporta l’ammissione della possibilità dell’esistenza di un infinito reale[9]. Tommaso lascia impregiudicato il dogma e discute la creazione in tutte le sue implicanze, fin dove la ragione può arrivare per conto suo[10]. Per Bonaventura invece, dove venne meno la saggezza dei filosofi, venne in soccorso la Sacra Scrittura, la quale afferma che ogni cosa è stata creata secondo tutto ciò che la costituisce nell’essere; e la ragione non è in disaccordo con la fede[11].
Nella sensibilità contemporanea questo dibattito provoca vari dibattiti sul rapporto tra teologia e scienza. Consideriamo che la linea bonaventuriana viene adottata da un autore contemporaneo come William Craig[12], basandosi sul pensiero di un matematico tedesco Georg Cantor (1845-1918). La tesi principale di questi autori è cosi sintetizzabile: mentre l’infinito attuale può essere un concetto coerente nel campo matematico, esso non si può applicare nel campo teologico, perché comporterebbe un’assurdità. Infatti, per Bonaventura solo Dio è infinito, ed egli non può produrre un altro infinito reale fuori di sé, perché sarebbe in contrasto con la natura di Dio stesso, cioè actus purus[13].
Dopo queste considerazioni sarà presentata una nuova prospettiva bonaventuriana, che viene chiamata “la nostra metafisica”, che si trova soprattutto in Hexaёmeron. Il punto fondamentale di questa nuova via è il Verbo divino. Egli è ratio aeterna della creazione dell’universo. Si tratta allora del Christus medium: Cristo come centro della vita Trinitaria e per questo centro dell’universo. In tale logica il discorso si approfondisce sul tema “Triplice Verbum”: Verbum increatum, incarnatum e inspiratum. Attraverso questa visione cristologica così intensa, scopriamo dunque il cuore teologico-metafisico di Bonaventura, che è caratterizzato dai tre pilastri fondamentali: emanazione, esemplarità e consumazione[14]. A questo punto si comprende che il suo pensiero teologico sulla creazione del mondo a sua volta mette in luce chi è Dio Creatore: Egli non è una sostanza in sé ma una persona in relazione. Ma qual è la sorgente di quest’orientamento?
Cercheremo di rispondere alla domanda precedente nel Secondo Capitolo. Il punto di partenza è la prospettiva anselmiana-bonaventuriana che definisce Dio come “il Sommo Bene, che è talmente perfetto che non si può pensare nulla di migliore”[15]. Siamo in tema di Trinità, causa suprema di tutti gli esseri. Per chiarire questa idea di Trinità creatrice, cercheremo allora di capire due nomi di Dio[16]. Il primo nome di Dio è l’Essere, oggetto primo della speculazione: “Io sono colui che sono” (Ex 3: 14). C’è un altro modo per contemplare Dio che consiste nel considerare la pluralità delle persone divine. A questo livello, si attribuisce a Dio il nome Bene: “Nessuno è buono se non solo Dio” (Mat 28: 19). Il nome Bonum disegna Dio considerandolo nel suo rapporto con la creatura. La bontà di Dio lo spinge a plasmare le creature perché esse partecipino della sua bontà.
Per Bonaventura il Padre è il principio della diffusione del Bene. Considerando la primitas di Dio Padre, egli scrive: “L’unità che rimane unica in più soggetti è più eccellente di quella che può mantenere la sua unità in una sola persona”[17]. “La primitas”, dice Bonaventura “non solo non esclude la Trinità, ma anzi la include in modo tale che il principio è trino per il fatto stesso che è primo”[18]. Si parla della primitas, ma primitas con il principio della diffusività del bene. È la logica applicazione del principio dionisiano – bonum diffusivum sui[19].
Applicata al processo trinitario, utilizzando l’argomento di Dio – carità elaborato da Riccardo di San Vittore, l’idea di espansione del Sommo Bene si esprime come Bonum communicativum. Il Bonum communicativum è la massima perfezione del Bonum diffusivum dionisiano. E per spiegare il rapporto tra le persone divine Bonaventura usa la parola circumincessio[20], intesa come una forma di assoluta donazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in virtù della quale si realizza il loro mutuo compenetrasi[21]. Da questo insegnamento dogmatico, si tratterà dell’attività della comunione trinitaria nella creazione.
Come si può comprendere la manifestazione divina della Trinità nella realtà creata? A questa domanda cercherà di rispondere il Terzo Capitolo del presente studio. Per Bonaventura, la volontà[22] di comunicarsi di un Dio che è bontà assoluta e amore infinito assicura le condizioni di possibilità perché vi sia il mondo creato: Il Padre è la primitas assoluta, summa caritas. L’atto creatore divino, considerato nella persona del Padre, deriva da lui in quanto principio. Il Figlio è l’immagine perfetta del Padre ed esemplare per eccellenza degli esseri creati. Come seconda persona della Trinità, Cristo è il medium di tutta la realtà. Lo Spirito è un dono gratuito da parte di Dio Trinità. Questo dono amorevole assicura che la volontà di Dio nel suo atto creativo sia libera.
Dato che la creazione è dono di Dio, ne consegue che la realtà creata non è semplicemente un qual cosa (res-reference) ma di più, è un segno (signum-meaning). In modo metaforico, il mondo viene paragonato a un libro[23] che manifesta il progetto di Dio, prima attraverso la realtà creata, poi nel libro divino, e infine, nel libro della vita che si manifesta pienamente in Cristo.
Se l’universo manifesta la grandezza del Creatore, allora, l’uomo può esprimere la presenza divina con il suo linguaggio pur avendo un limite. In altre parole, le creature sono vestigio, immagine e somiglianza di Dio. L’universo come macrocosmo è vestigio di Dio; l’uomo come microcosmo, pur avendo tripartizione nel suo essere, cioè memoria, intelletto e volontà, è l’immagine di Dio Trinità. Essere somiglianza di Dio vuol dire avere la capacità di accettare la grazia divina che porta l’anima all’unità con Dio: “Anima capax Dei”[24].
Questo discorso sui tre livelli della partecipazione alla realtà creata in Dio, lo possiamo comprendere seguendo la logica dell’Itinerarium. In effetti, l’Itinerarium propone tre livelli della nostra speculazione sulla presenza divina. La sensibilità ci rende capaci di ammirare la grandezza di Dio attraverso il macrocosmo (extra nos); come microcosmo l’uomo vede in sé l’immagine di Dio (intra nos); e con il dono della grazia santificante l’uomo salvato può alzare lo sguardo per contemplare il volto di Dio (supra nos). Parlando dell’uomo a somiglianza di Dio, si considera la necessità della grazia divina che culmina in Cristo. Cristo è l’unica porta della nostra salvezza[25].
Dopo aver trattato della trinità creatrice, nel Capitolo Quarto abbiamo cercato di verificare se questo sistema possa dare un contributo al dialogo tra teologia e scienza. Il concetto della trinità creatrice ci può aiutare a guardare il mondo come teofania? Per rispondere a questa domanda, è necessario capire qual è la metodologia che il magister ci suggerirebbe oggi. Bonaventura nell’opera De reductione artium ad theologiam si concentra sul metodo della reductio. Il suo scritto è una specie di discorso sul metodo, tendente a mostrare che la creazione, nel suo scopo finale, è ricondotta al suo punto di origine in Dio. È un metodo sapienziale perché considera il mondo come sacramento che disegna la presenza creativa di Dio.
Facendo riferimento a questo metodo, adattato a paradigma di convergenza[26] tra teologia e scienza, ne consegue che possiamo contemplare l’universo come una comunione universale, a partire da ciò che Dio è, cioè perfetta comunione. La scoperta scientifica ci dimostra che nell’universo c’è una dinamica dell’interconnettività tra gli organismi, non solo a livello macrocosmo ma anche nelle particelle più piccole degli esseri viventi. Nel linguaggio teologico si afferma chiaramente che l’amore è il cuore dell’energia primordiale della vita. Dio è amore, e l’amore cerca sempre la comunione.
Il nostro percorso giungerà infine a tre pilastri, auto-prodotto, differenziazione e complessità che disegnano analogicamente l’universo come un ordo; tutto ciò implica l’idea di una sinergia creatrice nell’universo. Auto-prodotto disegna la bontà del Padre. Il Padre è ratio principandi dalla quale emana la creatura. Differenziazione disegna il Christus Medium. Essendo medium nella Trinità, Cristo è ratio exemplandi dell’universo. Complessità si riferisce al dono dello Spirito: è il compimento della creazione e pertanto è ratio finiendi dell’ordo dell’universo[27].
Si può dunque confermare la tesi di partenza, secondo cui la prospettiva teologica di Bonaventura si presta ad un dialogo fecondo con la scienza su alcune questioni fondamentali, riguardo all’interpretazione dell’origine dell’universo. La categoria del bene, che si presenta agli occhi del magister come la categoria fondamentale per comprendere ciò che Dio manifesta di sé, è allo stesso tempo la categoria che può dare ragione di alcune dimensioni del mondo creato, che la stessa scienza mette in evidenza come strutturali nell’universo.
Quale valore può emergere dal pensiero teologico su Dio come il Supremo Bonum communicativum, che Bonaventura ci ha suggerito? Vi è un invito a vivere nel mondo curandolo come una “casa comune”[28], ciò che anche papa Francesco ha ricordato. Siamo chiamati a riconoscere che ogni organismo ha un valore “intrinseco” ed “è buono e mirabile in sé stesso per il fatto di essere una creatura di Dio”[29]. Il pensiero di Bonaventura che è derivato dall’esperienza di San Francesco d’Assisi sul Padre misericordioso, ci chiama ad amare Dio il sommo Bene sopra ogni cosa e a vivere il mondo come dono da restituire, così da non rimanere incurvati[30] chiudendoci egoisticamente, ma sempre in itinerario verso la comunione con Lui.
[1] O. Todisco, “La dimensione personale e comunitaria della fede cristiana. Suggestioni bonaventuriane”, in Aquinas, 45. 2 (2014), p. 382; Todisco,”Il Carattere Cristiano del Pensare Bonaventuriano, in DrSer, 61 (2013), p.17-18.
[2] M. Walz, “Bonaventure’s Argument” in ACPQ, 72 (1998), p., 85.
[3] II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 2 (II, 22); Cf. L. Bianchi, L’errore di Aristotele, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1984, p. 116.
[4] Cf. II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 2 resp. (II, 22ab).
[5] Sum. I, q. 46, a. 2, resp.: “sola fide tenetur, et demonstrative probari non potest”. Cf. Bianchi, L’errore di Aristotele, 121,124.
[6] I Sent., d. 44. a. 1. q. 4. concl. (I, 789): “Intelligendum est quod Deus potuit facere tempus ante hoc, et in illo facere mundum”.
[7] Cf. Bigi, “La dottrina della temporalità e del tempo”, in Ant 39 (1964), p. 450-45.
[8] I Sent. d. 8, p. 2, a. un, q. 2, resp. (I, 168b): “Creatura autem compositae sunt nec vere semplice, […] quia habent esse aliunde datum, quia habet esse post Deum unum, a quo deficiunt”; Cf. Hellmann, Divine and Created Order in Bonaventure’s Theology, The Franciscan Institute, St Bonaventure, NY., 2001, p. 85-88.
[9] Sancti Thomae de Aquino, Opera Omnia, De aeternitate mundi, 89: “Et preterea non est adhuc demonstratum quod Deus non posit facere ut sint infinita actu”. Cf. Walz, “Bonaventure’s Argument”, 94-95.
[10] Cf. A. Gishalberti, “La creazione nella filosofia di S. Tommaso d’Aquino”, in RFNS, 61 (1969), p. 203.
[11] II. Sent., d. 1, p.1, a.1, q.1 (II, 17).
[12] W. Craig, The Kālam Cosmological Argument, WIPF & STOCK, Eugene, 2000, p. 65-66, 69-70.
[13] I Sent., d. 43. a. u, q. 3 concl. (I, 772ab): “Infinitum in potentia Deus potest facere et facit; infinitum in actu non potest facere nec facit. Non potest, inquam, facere, quia nec convenit sibi, nec convenit creaturae. Cf. Houser and Noone, Commentary on the Sentences 263. Recentemente il tema dell’infinito è stato sviluppato nello studio di Kenan B. Osborne, OFM, The Infinity of God and a Finite World A Franciscan Approach, Franciscan Institute Publications, St Bonaventure University, NY, 2015.
[14] Hexaёm. I, 17 (V, 332).
[15] Itin., VI, 2; Cf. III, 4.
[16] Cf. Itin., cap. V e VI.
[17] Myst. Trin., q. 2. a. 2. f. 6 (V, 64b).
[18] Myst. Trin., q. 8, concl. (V, 114).
[19] Dionysius, de Caelest. Hiearach., 4 (Itin., VI, 2).
[20] Itin. VI, 2 (V, 310-311). Cf. Melone, “Circumincessio”, in DizBon, 230-231. Cf. Melone “La vita di Dio, ‘Summa Bonita et Caritas’, nel Mistero della Trinità”, in DrSer, 62 (2014), p.17-18.
[21] Cf. Itin. VI, 2 (V, 310-311).
[22] Cf. I Sent., d. 45, a. 2, q. 1 concl. (I, 804b); Cf. R. E. Houser and T.B. Noone, Commentary on the Sentences, Franciscan Institute Publication, St. Bonaventure University, NY., 2013, p. 228.
[23] Cf. Hexaёm., XII, 14 (V, 386).
[24] II Sent., d. 16, a. 1, q. 1, concl. (II, 395a): “Et hoc est quod dicit Augustinus, de Trinitate, decimo quarto, quod ‘eo est anima imago Dei quo capax eius et particeps esse potest’”.
[25] Il tema centrale dell’Itin. cap. IV e Brevil. part. IV.
[26] In epoca moderna questo metodo si è stato emerso nel pensiero del paleontologo gesuita Teilhard de Chardin (1881-1955) e viene sviluppato dagli autori contemporanei come Gisbert Greshake, John Haught, Anne Hunt, Denis Edwards, Zachary Hayes, Ilia Delio, etc.
[27] Cf. Brevil., pars. I, c. 6, n.1 (V, 215b).
[28] Pope Francis, Encyclical Letter Laudato Si’. On care of our Common Home, L’osservatore Romano, Città del Vaticano, 1.
[29] Pope Francis, Laudato Si’, 140; Cf. Denis Edwards, “Sublime Communion: The Theology of the Natural World in Laudato Si’”, in TheolStud, 77. 2 (2016), p. 381-382.
[30] Cf. E. Coughlin OFM, The Works of St. Bonaventure. Writing on the Spiritual Life, Franciscan Institute Publication St. Bonaventure University, NY., 2006, p. 10-11.